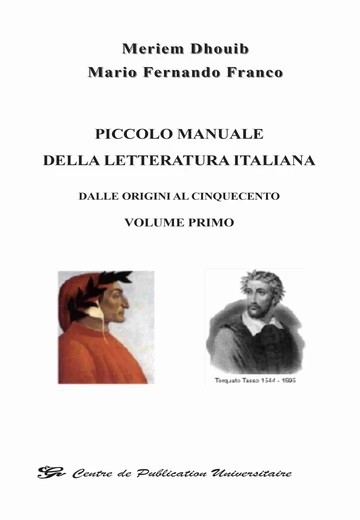L’accresciuto interesse per la lingua e la cultura italiana e il bisogno di disporre di uno strumento didattico sono le ragioni che hanno indottogli autori, prof.ssa meriem dhouib e prof. mario fernando franco, di questo “piccolo” manuale della letteratura italiana a riunire in tre volumi esperienze storiche letterarie dalle origini ai giorni nostri. l’originalità di questo manuale risiede nel fatto che non esiste oggi in tunisia uno simile che parta dalle origini fino al rinascimento e che sia concepito per gli studenti universitari di tutti i livelli. il piccolo manuale della letteratura italiana rispetta rigorosamente e con impegno scientifico gli elementi storici letterari trattati grazie anche ad un efficace approccio comunicativo supportato da diversi meccanismi pedagogici di apprendimento. infatti, nel rispetto degli aspetti teorici della letteratura, questo manuale trasforma le nozioni in un modo pratico e veloce attraverso esercizi proposti per ogni autore e testo. ho apprezzato molto questa démarche. nel suo complesso, l’antologia rispetta in pieno la metodologia dell’insegnamento moderno perché prevede contenuti esposti in forma chiara e metodica, introduzione del contesto storico illustrata in modo conciso ma diretto, sintesi biografica dei principali autori, tutto corredato da un linguaggio preciso, snello e accessibile. il manuale agevola la comprensione dei testi antichi da parte dello studente che ritrova a fronte sempre una versione in italiano moderno e grazie ad alcune letture critiche presenti in appendice può approfondire per ciascun secolo alcuni temi specifici di rilevanza storica, linguistica e letteraria. la bibliografia di gran pregio è esaustiva e valida dal punto di vista scientifico. non ultimo, la forma e l’impostazione grafica di grande pregio rendono molto piacevole la lettura. mi complimento con i due autori per il loro impegno a diffondere la cultura italiana in tunisia attraverso questo manuale che si rivela un rapido strumento didattico che conferisce allo studio della letteratura italiana una valenza di piacere intellettuale e di ricchezza conoscitiva abbracciare un arco di tempo letterario di simile importanza, “dalle orgini al cinquecento”, è una missione seriamente ambiziosa. ciò è diventato possibile nel presente manuale destinato ad un pubblico di studenti che iniziano il loro ingresso negli arcani di una letteratura dal grande destino europeo. gli autori meriem dhouib e mario franco due docenti universitari sono riusciti a mettere in risalto con efficacia la loro esperienza d’insegnamento nelle loro scelte didattiche. le prime testimonianze letterarie in italiano volgare sono delle poesie di argomento religioso: laude, come il celebre cantico di frate sole di san francesco d’assisi, testi medioevali in lode di dio e dei santi. nella prima metà del xiii secolo, la corte palermitana di federico ii era un vero centro della cultura che riunì attorno all’imperatore numerosi poeti come jacopo da lentini, il più illustre esponente della cosiddetta “scuola siciliana”. con l’emancipazione dal latino si poté parlare della nascita di una lingua “italiana” e di una letteratura italiana. il tema principale è l’amore e il servizio d’amore dovuto alla donna e alla maniera provenzale la nuova idea che nutre l’arte poetica italiana è l’amore cortese. l’innamorato canta in volgare il suo amore, che non viene ricambiato e della donna si cantano la bellezza e le virtù. la fama raggiunta dai poeti siciliani trovò una eco presso i poeti toscani ma l’atmosfera non è più più quella della monarchia siciliana ma quella della borghesia e dei liberi comuni toscani. tra il 1280 e i due primi decenni del trecento, nasce un altro tipo di poetica, quella del dolce stil novo con il suo iniziatore guido guinizelli. i poeti stilnovisti sono colti e raffinati e si considerano una elite intellettuale e nobili, non di sangue, ma di cuore. la tematica consacrata è quella della donna-angelo che fa da tramite tra dio e l’uomo. l’amore è una forza spirituale e solo un cuor gentile può migliorarsi, raggiungere la perfezione e provare questo sentimento. il dolce stil novo esprime il desiderio della borghesia del trecento preoccupata di conciliare la sua nuova visione della realtà concreta e legata ai piaceri della vita con la spiritualità religiosa del trecento. la classe nobiliare si trova soppiantata dall’intraprendenza borghese. tradizionalmente, le figure di dante, petrarca e boccaccio sono considerate il culmine di una civiltà e di momenti decisivi nel panorama letterario del trecento. si può dire che questo periodo suggella la fine del medioevo e preannunzia gli ideali umanistici. con la divina commedia, dante apre una nuova era nella letteratura italiana in lingua volgare, con il decameron, boccaccio la chiude e la tradizione novellistica prende una veste nuova tra divertimento esagaci insegnamenti di vita. quanto a petrarca, cantando l’amore per madonna laura, donna diversa dalla beatrice della vita nova di dante, l’autore del canzoniere celebra una donna divina dotata tuttavia di una bellezza umana che suscita in petrarca desideri amorosi e sofferenze. la cultura del quattrocento vede tornare la scrittura in lingua latinae i letterati ricercano la verità storico-filologica del passato per ritrovare i fasti della cultura antica. l’umanesimo si è ormai installato e le nuove idee si fanno strada. lo sviluppo della stampa permise la circolazione delle idee e della nuova visione dell’uomo e del mondo. nell’umanesimo, l’uomo è considerato al centro del mondo, artefice del proprio destino e protagonista della propria vita. in area italiana, la diffusione delle opere francesi dà origine, soprattutto a partire dal quattrocento, a un nuovo genere letterario, il poema cavalleresco, in cui si compie la sintesi tra il ciclo carolingio e il ciclo bretone quindi tra tematica eroica e quella amorosa. nel cinquecento, nascono così le opere di ariosto e tasso che veicolano argomenti epico- cavallereschi e reinterpretando occasioni di celebrazione dei valori della nuova società quella umanistico-rinascimentale. ad apertura dell’ orlando furioso, l’ariosto svela di voler cantare “le donne,/i cavalieri, l’arme, gli amori,/le cortesie, l’audaci imprese io canto” (i, 1). la mediazione del “ciclo bretone”, che percorre il poema del boiardo, l’orlando innamorato, arrichisce il tessuto epico con l’esperienza amorosa. nel contesto della controriforma, la gerusalemme liberata di torquato tasso, il cavaliere torna a essere l'eroe animato da forti ideali religiosi, ma è tormentato da passioni terrene. nel cinquecento si ricorda anche l’opera di angelo poliziano, erudita e poeta di rilievo, la nascita della prima tragedia regolare della storia della letteratura europea moderna con gian giorgio trissino. un altro registro è quello della raccolta di novelle, le novelle, di matteo bandello ognuna preceduta da una cornice diversa in cui palpita la vita quotidiana vissuta da uomini di chiesa, popolani, contadini, e “parvenus” che non scappano alla sua perspicacia. la lunga stagione letteraria del cinquecento si chiude con la crisi politica e religiosa e il periodo buio della controriforma. la censura ecclesiastica e politica, con l’inquisizione religiosa e l’inquisisione politica ebbero per missione quella di controllare e censurare le produzioni culturali e letterarie considerate sovversive e molti libri sono messi all’indice dei libri proibiti.